Posts Tagged: Viaggio
Il Museo del Giocattolo di Figueres
On luglio 21, 2015 by Cap Gazette With 0 Comments
- Spazi - Espais - Espacios

Per entrare al 'Museu del Joguet de Catalunya' di Figueres calpesto il gioco del mondo, quello che in realtà io ho sempre chiamato 'gioco della campana' e che qualcuno conosce anche come 'gioco della settimana', a seconda della parte d’Italia dove si è cresciuti. Oppure rayuela, xarranca, hopscotch, marelles, ula, tempelhupfen se siamo stati bambini in Argentina o in Catalunya, in Inghilterra o in Francia, in Nepal o in Germania. Una volta dentro, una riproduzione della Tour Eiffel del 1929 mi sembra lì per lì un bel modo per accogliere i visitatori che, oggi per lo meno, sono soprattutto francesi (fra un po’ capirò che la struttura vuole essere un esempio di grande meccano: 9.832 pezzi e 8.623 viti).
Il confine con la Francia è effettivamente a pochi chilometri da Figueres, nota prevalentemente per lo strampalato e capriccioso museo voluto da Dalì, che è infatti il motivo principale del passaggio in città di molti turisti. Mi chiedo se la vicinanza tra i due musei giovi al più piccolo o saranno solo coloro che viaggiano con bambini a visitare anche il 'Museo del Giocattolo'? Fosse così sarebbe un peccato, venendo qui incontreremmo infatti un grillo parlante desideroso di riaccompagnarci tra le stramberie dell'infanzia nostra, dei nostri genitori, nonni e bisnonni. Forse il grillo ce le canterebbe pure, per essere diventati troppo seriosamente adulti, e di un grillo parlante c'è da fidarsi...
Il confine con la Francia è effettivamente a pochi chilometri da Figueres, nota prevalentemente per lo strampalato e capriccioso museo voluto da Dalì, che è infatti il motivo principale del passaggio in città di molti turisti. Mi chiedo se la vicinanza tra i due musei giovi al più piccolo o saranno solo coloro che viaggiano con bambini a visitare anche il 'Museo del Giocattolo'? Fosse così sarebbe un peccato, venendo qui incontreremmo infatti un grillo parlante desideroso di riaccompagnarci tra le stramberie dell'infanzia nostra, dei nostri genitori, nonni e bisnonni. Forse il grillo ce le canterebbe pure, per essere diventati troppo seriosamente adulti, e di un grillo parlante c'è da fidarsi...
In realtà arriveremo a epoche ancor più remote, se teniamo conto che nella prima sala del museo sono esposti giochi dell’antichità greca e di quella romana ritrovati negli scavi di Tarragona e in quelli di Empúries: bambole e poi dadi, pedine e tavolieri di osso, fango o avorio.
Tra l’altro, anche il gioco del mondo che ci dà il benvenuto all’entrata pare che abbia origini assai lontane, per la precisione nell’antico Egitto, e che poi si sia diffuso in tutta Europa sui selciati dell’Impero Romano, quando il gioco veniva detto ‘dello zoppo’ (claudus).
La maggior parte degli oggetti in mostra appartengono alla collezione di Josep Maria Joan Rosa che li ha donati alla sua città, dopo aver raccolto per anni centinaia di giochi di tutti i tipi e provenienze.
Tra l’altro, anche il gioco del mondo che ci dà il benvenuto all’entrata pare che abbia origini assai lontane, per la precisione nell’antico Egitto, e che poi si sia diffuso in tutta Europa sui selciati dell’Impero Romano, quando il gioco veniva detto ‘dello zoppo’ (claudus).
La maggior parte degli oggetti in mostra appartengono alla collezione di Josep Maria Joan Rosa che li ha donati alla sua città, dopo aver raccolto per anni centinaia di giochi di tutti i tipi e provenienze.

La suddivisione che ci viene proposta è tematica e i primi giochi che troviamo sono quelli che si fanno all’aperto, quindi pattini, monopattini, tricicli, birilli, corde, palle, trottole, cerchi (o hula-hop) e biglie. Subito dopo vengono i giochi legati al tema del viaggiare e qui la parte del leone la fanno i trenini elettrici e le autombili d’altri tempi, soprattutto dei primi decenni del Novecento e di fabbricazione catalana, spagnola, tedesca e inglese. C’è per esempio un bel modellino del vecchio tram della linea Gracia-Bonanova, attualmente due quartieri di Barcellona, e una riproduzione degli anni Venti di un taxi sempre della capitale catalana.
Il percorso continua con la parte dedicata agli animali, prevalentemente di cartone, dove non mancano però il cavallino a dondolo e gli orsetti, tra cui Don Osito Marquina, l’orsetto con cui giocavano Dalì e la sorella.
Dopo la sezione dei giochi da tavolo, c’è quella riservata alla vita di famiglia che raccoglie bambolotti e bambole, cucine e negozi in miniatura; c’è anche una bambola stesa sul lettino di una sala operatoria specializzata in ‘operazioni senza dolore’. Altre bambole sono di fabbricazione torinese e risalenti agli anni Venti del secolo scorso; un altro pezzo forte è una delle prime Barbie della Mattel, datata 1959. In questa zona del museo è stata esposta anche una sezione davvero insolita di ambientazione religiosa, con bambole-suore e aule con la riproduzione di una lezione di religione e poi altari, processioni e indumenti sacri di vario genere.
Dopo la sezione dei giochi da tavolo, c’è quella riservata alla vita di famiglia che raccoglie bambolotti e bambole, cucine e negozi in miniatura; c’è anche una bambola stesa sul lettino di una sala operatoria specializzata in ‘operazioni senza dolore’. Altre bambole sono di fabbricazione torinese e risalenti agli anni Venti del secolo scorso; un altro pezzo forte è una delle prime Barbie della Mattel, datata 1959. In questa zona del museo è stata esposta anche una sezione davvero insolita di ambientazione religiosa, con bambole-suore e aule con la riproduzione di una lezione di religione e poi altari, processioni e indumenti sacri di vario genere.

Dopo le bambole si passa ai teatrini e ai palcoscenici, alle marionette e ai burattini e ai giochi di magia con l’immancabile scatola del piccolo prestigiatore e qualche testo e oggetto del poeta Joan Brossa. Tra i divertimenti ‘ottici’ sono stati invece raccolti alcuni modelli degli Anni Trenta di cinematografi portatili, il ‘Cine Nic’, un’evoluzione della lanterna magica che divenne la passione di molti bambini spagnoli, i quali potevano anche creare il proprio film, disegnando prima le scenette su una carta apposita; usando la versione munita di grammofono, potevano addirittura sceglierne la banda sonora. Vediamo anche il dispositivo ottico dello zootropio (dal greco ‘giro della vita’), strumento giratorio per la magia delle immagini in movimento.

Oltre a soldati e a giochi di ‘guerra per scherzo’, dietro le vetrine troveremo poi innumerevoli figure di latta con i personaggi più insoliti, maschere, giochi per non vedenti e strumenti musicali, carte da gioco, il cubo magico e chi più ne ha, più ne metta.
Tra i fumetti è presente ovviamente il TBO, famoso settimanale di storie illustrate e umoristiche che venne pubblicato in Spagna tra il 1917 e il 1998; fra le vecchie pagine spicca la figura in cartone dell’illustre Doctor de Copenhague che era colui che presentava la sezione della rivista dedicata alle grandi invenzioni, probabilmente una delle poche concessioni europeiste sotto il franchismo, recitano le informazioni ai suoi piedi.
Tra i fumetti è presente ovviamente il TBO, famoso settimanale di storie illustrate e umoristiche che venne pubblicato in Spagna tra il 1917 e il 1998; fra le vecchie pagine spicca la figura in cartone dell’illustre Doctor de Copenhague che era colui che presentava la sezione della rivista dedicata alle grandi invenzioni, probabilmente una delle poche concessioni europeiste sotto il franchismo, recitano le informazioni ai suoi piedi.

Del gioco dell’oca ritroviamo diversi esemplari; si tratta probabilmente del più famoso gioco di percorso che sia mai esistito. Con il suo tragitto a spirale rappresenta la vita: una serie di ostacoli da superare e poi l’arrivo al giardino dell’oca, simbolo del bene ma anche del ritorno alle origini. A proposito di origini, pare che Ferdinando de’ Medici ne avesse regalato uno al re Filippo IIº di Spagna già nella seconda metà del Cinquecento, ma l’oca era già stato animale molto apprezzato da civiltà ben più antiche: i Celti, gli Egizi ed anche i Romani che avevano eletto le oche a guardiane del tempio di Giunone. Prima di arrivare al corridoio che ci porta alla fine del museo dove si rende omaggio ai più importanti costruttori di giocattoli, la sorpresa del ricordo, e anche un po’ di nostalgia, conducono di nuovo tra peluche, costruzioni di carta, Meccano, valigette zeppe di piccoli oggetti.
Al termine della visita ritorniamo all'inizio, laddove ci era stato raccontato che uno dei più antichi giochi da tavolo e di percorso, il 'Gioco reale di Ur' risalente al 2600-2400 a.C., fu rinvenuto negli anni Venti del Novecento nelle tombe reali della città sumera; perfino durante il viaggio eterno fu, e sarà, importante continuare a giocare.
Text&Foto: Baldassar Perruccio © CapGazette
Settembre 2015
Text&Foto: Baldassar Perruccio © CapGazette
Settembre 2015
Italiano via Skype
On luglio 2, 2015 by Cap Gazette With 0 Comments
- Italiano via Skype

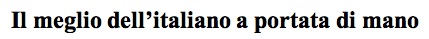
A loro offriamo via Skype:
✔ lezioni di italiano, da un livello A1 a un livello C2 del 'Quadro Comune Europeo delle Lingue'
✔conversazione in italiano, di livello intermedio e avanzato
✔ italiano per le aziende e per gli affari
✔ preparazione agli esami di certificazione ufficiale CELI e CILS.
✔ servizi di consulenza linguistica e di traduzione:
catalano ➞ italiano // italiano ➞ catalano
inglese ➞ italiano
francese ➞ italiano
portoghese ➞ italiano
info@capgazette.com

Le barche. In partenza da Barcellona, sulle rotte d’altri tempi
On giugno 26, 2015 by Cap Gazette With 0 Comments
- Argumento - Argument - Argomento
In partenza da Barcellona, sulle rotte d'altri tempi

Tra il tredicesimo e il quindicesimo secolo le navi che salpavano dal porto di Barcellona, battendo bandiera catalano aragonese, si dirigevano verso il Mediterraneo occidentale o quello orientale e verso i paesi del nord. Come cambiava il commercio col percorso marittimo?
Verso la Sicilia viaggiavano tessuti e armamenti, olio di Mallorca, riso di Valencia e miele di Tortosa, mentre sulla stessa rotta ma in senso contrario venivano trasportati il grano e lo zucchero (caricati a Palermo e a Messina erano destinati a raggiungere più tardi anche i paesi del Nord), la seta, il cotone e il corallo. A Napoli, che era un porto molto importante per gli scambi internazionali, ci si riforniva invece di vino bianco e rosso e di magnifici cavalli e i catalani vi vendevano zafferano, cera e sale di Ibiza.
Verso la Sicilia viaggiavano tessuti e armamenti, olio di Mallorca, riso di Valencia e miele di Tortosa, mentre sulla stessa rotta ma in senso contrario venivano trasportati il grano e lo zucchero (caricati a Palermo e a Messina erano destinati a raggiungere più tardi anche i paesi del Nord), la seta, il cotone e il corallo. A Napoli, che era un porto molto importante per gli scambi internazionali, ci si riforniva invece di vino bianco e rosso e di magnifici cavalli e i catalani vi vendevano zafferano, cera e sale di Ibiza.
In Nord Africa, soprattutto a Tunisi e a Algeri, si commerciavano utensili agricoli e stoffe in cambio d’oro e di schiavi, di corallo e di cera.
Anche sulla via del Levante, solcata prevalentemente da quelle grandi potenze marittime che furono Genova e Venezia, le navi catalane si guadagnarono un certo prestigio. Toccavano solitamente i porti di Alghero, Cagliari, Gaeta, Napoli, Palermo, Messina, Siracusa e Rodi e da qui prendevano la rotta che portava o a Beirut o a Alessandria d’Egitto. Il viaggio variava dai tre ai tredici mesi, a seconda degli scali, ma al ritorno, prima di approdare nuovamente a Barcellona, l’ultima tappa era sempre quella che si effettuava sull’isola di Mallorca.
Anche sulla via del Levante, solcata prevalentemente da quelle grandi potenze marittime che furono Genova e Venezia, le navi catalane si guadagnarono un certo prestigio. Toccavano solitamente i porti di Alghero, Cagliari, Gaeta, Napoli, Palermo, Messina, Siracusa e Rodi e da qui prendevano la rotta che portava o a Beirut o a Alessandria d’Egitto. Il viaggio variava dai tre ai tredici mesi, a seconda degli scali, ma al ritorno, prima di approdare nuovamente a Barcellona, l’ultima tappa era sempre quella che si effettuava sull’isola di Mallorca.
Sulla rotta del Levante, chiamata anche rotta d’Oriente o d’Oltremare, il commercio più importante era indubbiamente quello delle spezie: pepe, incenso, mirra, zenzero, cannella e sandalo venivano scambiati con corallo, olio, nocciole, mandorle, piante aromatiche e zafferano, l’unica spezia esportata dal Mediterraneo occidentale. I preziosi tessuti di Damasco venivano scambiati con panni più economici, con lana e col vino liquoroso di Cipro. Il benessere dei mercanti, degli artigiani e dei contadini della corona catalano aragonese dipendeva prevalentemente dagli affari commerciali della rotta di Siria e Egitto: le entrate che si ricavavano dalla vendita dei prodotti acquistati in Oriente e riesportati in Castiglia, in Provenza e nei paesi del Nord dovevano infatti assicurare il lavoro nelle botteghe artigianali e nei campi dei territori della Corona.
Sulla rotta atlantica le navi che partivano da Barcellona toccavano i porti dell’Almeria, di Malaga, di Siviglia, di Cadice, di Lisbona per poi avventurarsi verso la Manica in direzione dell’Inghilterra o delle Fiandre.
Sulla rotta atlantica le navi che partivano da Barcellona toccavano i porti dell’Almeria, di Malaga, di Siviglia, di Cadice, di Lisbona per poi avventurarsi verso la Manica in direzione dell’Inghilterra o delle Fiandre.

Oltre a tutte le altre mercanzie che giungevano dai paesi del Levante o dalla Sicilia, i prodotti che solcavano queste acque erano prevalentemente alimenti in grado di sopportare il lugno viaggio: fichi secchi, mandorle, pinoli ed infine lo zafferano che nelle Fiandre veniva usato sia come spezia, che come colorante nella tinteggiatura dei tessuti.
Dai paesi del Nord si importavano metalli, in particolar modo il ferro che serviva a fabbricare coltelli e armi, pelli scandinave e russe, cappelli, berretti e piume per riempire i cuscini, stoffe d’ogni genere ed infine il legname.
Parliamo di mercanzie ma con loro anche di mercanti, crociati e pellegrini, di soldati alla mercé della corte, di uomini, donne e bambini che venivano trasportati nelle terre conquistate per ripopolarle; umanità in movimento e legami tra terre lontane, di cui ancor oggi rimane traccia nelle lingue e nelle tradizioni popolari, nei tratti somatici e nei caratteri delle persone.
Dai paesi del Nord si importavano metalli, in particolar modo il ferro che serviva a fabbricare coltelli e armi, pelli scandinave e russe, cappelli, berretti e piume per riempire i cuscini, stoffe d’ogni genere ed infine il legname.
Parliamo di mercanzie ma con loro anche di mercanti, crociati e pellegrini, di soldati alla mercé della corte, di uomini, donne e bambini che venivano trasportati nelle terre conquistate per ripopolarle; umanità in movimento e legami tra terre lontane, di cui ancor oggi rimane traccia nelle lingue e nelle tradizioni popolari, nei tratti somatici e nei caratteri delle persone.

Nel 1490 venne pubblicata a Valencia un’opera dello scrittore Joanot Martorell, dal titolo Tirant lo Blanc, destinato a diventare un classico della letteratura catalana medievale. Il libro narra le avventure cavalleresche di Tirant e del suo amore per Carmesina, la figlia dell’imperatore greco; le terre che l’eroe percorre evocano le rotte marittime commerciali di cui abbiamo parlato: l’Inghilterra, la Sicilia, Rodi, Costantinopoli, il Nord Africa.
Le stesse leggende popolari catalane sono costellate da personaggi che sono i protagonisti, e i testimoni, di una storia densa di avventure per mare; per esempio il Pescatore di Corallo, che è la vicenda di un povero orfano che un giorno, all’epoca del re Pietro, venne portato con altri giovani ad Alghero per ripopolare la terra. La leggenda racconta che giunto nell’isola, il ragazzino iniziò a lavorare come
Le stesse leggende popolari catalane sono costellate da personaggi che sono i protagonisti, e i testimoni, di una storia densa di avventure per mare; per esempio il Pescatore di Corallo, che è la vicenda di un povero orfano che un giorno, all’epoca del re Pietro, venne portato con altri giovani ad Alghero per ripopolare la terra. La leggenda racconta che giunto nell’isola, il ragazzino iniziò a lavorare come
pescatore e in una mattina di festa, mentre passeggiava per il paese, all’improvviso vide uscire dalla messa una donna bellissima e se ne innamorò perdutamente. La fanciulla era la figlia del Signore (veguer) d’Alghero ed abitava in un sontuoso palazzo affacciato sul mare. Un giorno il pescatore trovò in fondo al mare un ramo di corallo rosso, lo strappò, tornò a galla e corse a darlo in dono all’amata fanciulla. La figlia del Signore rimase abbagliata dalla generosità del pescatore e dalla preziosità di quel dono e gli chiese di portargliene ancora. Il ragazzo obbedì e per molte notti si aggrappò agli scogli sui quali si ergeva il palazzo dell’innamorata e arrampicatosi fino alla finestra tendeva la mano e le porgeva il corallo. Fin quando in una notte malaugurata, il padre della ragazza, messo al corrente di quegli incontri segreti, lo aspettò; quando il pescatore iniziò a salire per le rocce, l'uomo lo spinse e lo fece cadere giù. Il ragazzo andò a sbattere contro gli scogli e precipitò in mare. Si narra che il suo corpo senza vita venne trasportato fino alle grotte di Nettuno dove nelle notti di mare calmo ancor oggi si vede crescere altissimo sul turchese dell’acqua un ramo di rosso corallo.

Madre, se fossi marinaio,
marinaio di quelli buoni,
me ne andrei in alto mare
solo con la mia barca;
il vento sarebbe un grido di gioia,
la vela, colomba bianca,
il cuore d'un blu come d'incanto
e gli occhi d'un verde di speranza.
marinaio di quelli buoni,
me ne andrei in alto mare
solo con la mia barca;
il vento sarebbe un grido di gioia,
la vela, colomba bianca,
il cuore d'un blu come d'incanto
e gli occhi d'un verde di speranza.
Se in quelle notti invece il mare fosse in burrasca, vi potrebbe capitare di avvistare all’orizzonte la Barca dei dormono e cantano e di sentire le voci dei “mori” destinati a una fuga perenne fin dall’epoca in cui Giacomo I° conquistò Mallorca. Pare che durante la notte queste anime in pena arrivino fino alla fine del mondo e che da lì tornino alle nostre acque. Tra i lampi, forse scorgereste le fiamme delle vele del vascello che arde e sentireste l’equipaggio russare o cantare all’infinito.
Text: Baldassar Perruccio © CapGazette
Trad. poesia di Miquel Martí i Pol: Paolo Gravela © CapGazette
Foto: © Renata Scanu
Luglio 2015
Chisciotte 1
On giugno 24, 2015 by Cap Gazette With 0 Comments
- Letture - Lectures - Lecturas


Don Quijote de la Mancha
Primero
CAPÍTULO 1
Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo D. Quijote de la Mancha.
Página 1
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben; aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad [...]
Primero
CAPÍTULO 1
Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo D. Quijote de la Mancha.
Página 1
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben; aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad [...]

Don Chisciotte della Mancia
Primo
CAPITOLO 1
Che tratta della condizione ed esercizio del famoso idalgo D. Chisciotte della Mancia.
Pagina 1
In un paese della Mancia, del cui nome non mi voglio ricordare, non molto tempo fa viveva un nobiluomo di quelli con lance nella rastrelliera, emblema araldico antico, ronzino magro e cane sparviero. Una pentola più di vacca che di montone, trito in salsa il più delle sere, resti e ossa il sabato, lenticchie il venerdì, qualche piccione in aggiunta la domenica, consumavano i tre quarti delle sue rendite. Il resto se ne andava in un saio di panno scuro, calzoni di velluto per le feste con pantofole di velluto anch’esse, mentre nei giorni feriali si agghindava di finissimo albagio. Teneva in casa una domestica di quarant’anni e passa, e una nipote che non ne aveva ancora venti, e un ragazzo buono per la campagna e la piazza, capace di sellare il ronzino e di maneggiare la roncola per potare. Si accostava l’età del nostro idalgo ai cinquant’anni, era di costituzione robusta, di carni secche, asciutto in viso; mattiniero nelle abitudini e amico della caccia. Vogliono alcuni che fosse chiamato Chisciata o Caseata, che su questo vi sono alcune divergenze tra gli autori che di questo caso scrivono; sebbene per congetture verosimili si lasci intendere che si chiamasse Chisciana; ma questo importa poco al nostro racconto; basta che nella sua narrazione non ci si scosti un punto dalla verità [...]
Primo
CAPITOLO 1
Che tratta della condizione ed esercizio del famoso idalgo D. Chisciotte della Mancia.
Pagina 1
In un paese della Mancia, del cui nome non mi voglio ricordare, non molto tempo fa viveva un nobiluomo di quelli con lance nella rastrelliera, emblema araldico antico, ronzino magro e cane sparviero. Una pentola più di vacca che di montone, trito in salsa il più delle sere, resti e ossa il sabato, lenticchie il venerdì, qualche piccione in aggiunta la domenica, consumavano i tre quarti delle sue rendite. Il resto se ne andava in un saio di panno scuro, calzoni di velluto per le feste con pantofole di velluto anch’esse, mentre nei giorni feriali si agghindava di finissimo albagio. Teneva in casa una domestica di quarant’anni e passa, e una nipote che non ne aveva ancora venti, e un ragazzo buono per la campagna e la piazza, capace di sellare il ronzino e di maneggiare la roncola per potare. Si accostava l’età del nostro idalgo ai cinquant’anni, era di costituzione robusta, di carni secche, asciutto in viso; mattiniero nelle abitudini e amico della caccia. Vogliono alcuni che fosse chiamato Chisciata o Caseata, che su questo vi sono alcune divergenze tra gli autori che di questo caso scrivono; sebbene per congetture verosimili si lasci intendere che si chiamasse Chisciana; ma questo importa poco al nostro racconto; basta che nella sua narrazione non ci si scosti un punto dalla verità [...]
Text: Miguel de Cervantes / Trad ita e foto: Paolo Gravela / ©CapGazette, oct 2014
Chisciotte 2
On giugno 21, 2015 by Cap Gazette With 0 Comments
- Letture - Lectures - Lecturas

Don Chisciotte e Sancio Panza visti da Albert Àlvarez
Don Chisciotte della Mancia
Secondo
Un anno dopo proponiamo il secondo paragrafo del Don Quijote e la sua corrispondete traduzione in italiano. Abbiamo calcolato che continuando così, saranno sufficienti 1.800 anni per finire di tradurlo, a meno che il traduttore, come si ripromette epicamente di fare, non smetta di fumare, sostituendo il tabacco con la traduzione ossessiva compulsiva. Non disperiamo.
Secondo
Un anno dopo proponiamo il secondo paragrafo del Don Quijote e la sua corrispondete traduzione in italiano. Abbiamo calcolato che continuando così, saranno sufficienti 1.800 anni per finire di tradurlo, a meno che il traduttore, come si ripromette epicamente di fare, non smetta di fumare, sostituendo il tabacco con la traduzione ossessiva compulsiva. Non disperiamo.
[...] Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso - que eran los más del año - se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva: porque la claridad de su prosa, y aquellas intrincadas razones suyas, le parecían de perlas; y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican, y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza.
Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas, y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara, ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para sólo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía porque se imaginaba que, por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma, y darle fin al pie de la letra, como allí se promete; y sin duda alguna lo hiciera, y aun saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar —que era hombre docto, graduado en Cigüenza— sobre cuál había sido mejor caballero: Palmerín de Ingalaterra o Amadís de Gaula; mas maese Nicolás, barbero del mesmo pueblo, decía que ninguno llegaba al Caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga [...]
Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas, y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara, ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para sólo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía porque se imaginaba que, por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma, y darle fin al pie de la letra, como allí se promete; y sin duda alguna lo hiciera, y aun saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar —que era hombre docto, graduado en Cigüenza— sobre cuál había sido mejor caballero: Palmerín de Ingalaterra o Amadís de Gaula; mas maese Nicolás, barbero del mesmo pueblo, decía que ninguno llegaba al Caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga [...]
[...] Bisogna, quindi, sapere, che questo suddetto nobiluomo, nei momenti in cui era ozioso - che erano i più dell’anno - si metteva a leggere libri di cavalleria con così tanta passione e gusto, da dimenticare quasi del tutto l’esercizio della caccia, e pure l’amministrazione della sua tenuta; e in ciò giunsero a tanto la sua curiosità e il suo sproposito, che vendette molte giornate di terra da semina per comprare libri di cavalleria da leggere; e così si portò a casa quanti di essi riuscì ad avere; e tra tutti nessuno gli pareva pari a quelli composti dal famoso Feliciano de Silva: poiché la chiarezza della sua prosa, e quei suoi intricati ragionamenti, gli parevano di perle; e più ancora quando arrivava a leggere quelle galanteria e lettere di sfida, nelle quali ovunque trovava scritto: la ragione del torto che alla mia ragione si fa, in tal modo la mia ragione indebolisce, che a ragion veduta lamento la vostra beltà, e anche quando leggeva: gli alti cieli che della vostra divinità divinamente con le stelle si fortificano, e vi fanno meritevole del merito che merita la vostra grandezza.
Con questi ragionamenti perdeva il povero cavaliere il senno, e si tormentava per capirli, e sviscerarne il senso, che non l’avrebbe svelato, né compreso Aristotele stesso, nemmeno resuscitando solo per questo. Non lo convincevano del tutto le ferite che don Belianis dava e buscava poiché immaginava che, per quanto grandi i maestri che l’avevano curato, non avrebbe certo potuto evitare di avere il viso e tutto il corpo pieni di cicatrici e segni. Ciononostante, lodava dell’autore qual suo concludere il libro con la promessa di quella interminabile avventura, e molte volte gli venne voglia di prendere la penna, e finirlo per filo e per segno, come lì si promette; e senza dubbio l’avrebbe fatto, e ci sarebbe riuscito, se altri maggiori e continui pensieri non gliel’avessero impedito. Ebbe molte volte da discutere con il curato del villaggio - che era uomo dotto, diplomato a Sigüenza - su quale fosse stato migliore cavaliere: Palmerino d’Inghilterra o Amadigi di Gaula; ma mastro Nicolás, barbiere dello stesso paese, diceva che nessuno era pari al Cavaliere del Febo, e che se qualcuno gli si poteva paragonare era don Galaorre, fratello di Amadigi di Gaulia, perché disponeva di condizione molto acconcia a tutto; che non era cavaliere sdolcinato, né lagnoso come suo fratello, e in quanto a coraggio non gli era secondo [...]
Con questi ragionamenti perdeva il povero cavaliere il senno, e si tormentava per capirli, e sviscerarne il senso, che non l’avrebbe svelato, né compreso Aristotele stesso, nemmeno resuscitando solo per questo. Non lo convincevano del tutto le ferite che don Belianis dava e buscava poiché immaginava che, per quanto grandi i maestri che l’avevano curato, non avrebbe certo potuto evitare di avere il viso e tutto il corpo pieni di cicatrici e segni. Ciononostante, lodava dell’autore qual suo concludere il libro con la promessa di quella interminabile avventura, e molte volte gli venne voglia di prendere la penna, e finirlo per filo e per segno, come lì si promette; e senza dubbio l’avrebbe fatto, e ci sarebbe riuscito, se altri maggiori e continui pensieri non gliel’avessero impedito. Ebbe molte volte da discutere con il curato del villaggio - che era uomo dotto, diplomato a Sigüenza - su quale fosse stato migliore cavaliere: Palmerino d’Inghilterra o Amadigi di Gaula; ma mastro Nicolás, barbiere dello stesso paese, diceva che nessuno era pari al Cavaliere del Febo, e che se qualcuno gli si poteva paragonare era don Galaorre, fratello di Amadigi di Gaulia, perché disponeva di condizione molto acconcia a tutto; che non era cavaliere sdolcinato, né lagnoso come suo fratello, e in quanto a coraggio non gli era secondo [...]
Texto: Miguel de Cervantes
Traduzione: Paolo Gravela
Disegno: Albert Àlvarez
CapGazette 6/2015
Traduzione: Paolo Gravela
Disegno: Albert Àlvarez
CapGazette 6/2015
Un síndrome literario
On giugno 17, 2015 by Cap Gazette With 0 Comments
- Letture - Lectures - Lecturas


Lo que más me fastidia de Stendhal es la hache: nunca sé si se escribe Stendhal o Stendahl y siempre me equivoco. Pero, por lo demás, es uno de mis autores favoritos, con los que más me divierto, a los que más admiro.
Escribió como vivió, de modo impetuoso, apasionado y despreocupado.
La primera vez que estuvo en Italia vestía el uniforme de dragones del ejército francés. Lo empleó en el campo de batalla y en el teatro de la ópera, y fue en Italia donde comenzó a escribir. Luego abandonó el ejército, pero a las órdenes de la administración bonapartista viajó por toda Europa y fue testigo directo de la campaña de Rusia. Roma, Nápoles y Florencia (1817) comienza con el recuerdo de esa cruel derrota. Stendhal se dice incapaz de apreciar la belleza de un paisaje nevado desde que vivió la Gran Retirada. De refilón, recuerda cuando tapiaban las ventanas de un hospital de campaña con los miembros amputados a los heridos, siniestros ladrillos que evitaron la muerte por congelación de los que ahí se habían refugiado de la tormenta.
Así, con esa imagen aterradora, Stendhal deja atrás la nieve y el hielo y se adentra en la que sería su patria de adopción, Italia, en el relato de su primer gran viaje a Italia. Deja atrás el frío del norte y se adentra en el cálido sur.
En Roma, Nápoles y Florencia se muestra locuaz y divertido, encantado de conocerse, felicísimo de estar ahí. Cuando no acierta a rescatar de la memoria tal o cual suceso, no tiene reparos en inventárselo y nos contagia su alegría. Por eso, siempre, siempre, recomiendo comparar este texto con los diarios del viaje a Italia de Goethe. El alemán es sutil, bello, elegante, intelectual, mientras Stendhal es vital, sensual, de ninguna manera contemplativo. Tan próximos, tan diferentes.
Con todo, es Stendhal el afortunado a la hora de bautizar el síndrome más poético de los desórdenes psicológicos pasajeros, el famoso y reconocido síndrome de Stendhal.
El síndrome fue descrito por vez primera por una psiquiatra florentina, Graziella Margherini. Es una crisis de ansiedad que desemboca en un episodio depresivo. Suele ser pasajero. La contemplación de tanta belleza en personas sensibles y predispuestas a ello parece ser la causa y en Florencia no faltan bellezas que contemplar.
La doctora Margherini tuvo a bien inspirarse en un fragmento de Roma, Nápoles y Florencia, el que describe el agotamiento de Stendhal después de visitar la Santa Croce.
Traducido por Elisabeth Falomir, el fragmento dice así:
«Estaba ya en una suerte de éxtasis ante la idea de estar en Florencia y por la cercanía de los grandes hombres cuyas tumbas acababa de ver. Absorto en la contemplación de la belleza sublime, la veía de cerca, la tocaba, por así decir. Había alcanzado ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes inspiradas por las bellas artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de la Santa Croce, me latía con fuerza el corazón; sentía aquello que en Berlín denominan nervios; la vida se había agotado en mí y caminaba temeroso de caerme.»
Con todo, es Stendhal el afortunado a la hora de bautizar el síndrome más poético de los desórdenes psicológicos pasajeros, el famoso y reconocido síndrome de Stendhal.
El síndrome fue descrito por vez primera por una psiquiatra florentina, Graziella Margherini. Es una crisis de ansiedad que desemboca en un episodio depresivo. Suele ser pasajero. La contemplación de tanta belleza en personas sensibles y predispuestas a ello parece ser la causa y en Florencia no faltan bellezas que contemplar.
La doctora Margherini tuvo a bien inspirarse en un fragmento de Roma, Nápoles y Florencia, el que describe el agotamiento de Stendhal después de visitar la Santa Croce.
Traducido por Elisabeth Falomir, el fragmento dice así:
«Estaba ya en una suerte de éxtasis ante la idea de estar en Florencia y por la cercanía de los grandes hombres cuyas tumbas acababa de ver. Absorto en la contemplación de la belleza sublime, la veía de cerca, la tocaba, por así decir. Había alcanzado ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes inspiradas por las bellas artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de la Santa Croce, me latía con fuerza el corazón; sentía aquello que en Berlín denominan nervios; la vida se había agotado en mí y caminaba temeroso de caerme.»
La editorial Gadir publicó El síndrome del viajero (Diario de Florencia), un fragmento de Roma, Nápoles y Florencia, del que he copiado el párrafo anterior. Como es un libro pequeñito, me lo llevé conmigo la última vez que estuve en Florencia y tan pronto salí de la Santa Croce, en una suerte de éxtasis, me senté en un banco frente a la iglesia, abrí el librito y leí. También sentí que la vida se había agotado en mí y caminaba temeroso de caerme.
Pero tengo que añadir que ya llevaba varios días en la ciudad y pocas veces había caminado tanto en mi vida. Aunque fue un momento emocionante ¡y vaya si lo fue!, tengo que señalar que la mayor parte de las veces se confunde el síndrome de Stendhal con puro agotamiento, insolación o deshidratación, y siento restarle emoción al cuento. Aunque la emoción la pone cada uno a lo que siente, por qué no. Si bien es cierto que casos clínicos de tan particular ansiedad se dan pocas veces al año en Florencia, se dan, y si un turista como un servidor de ustedes se emociona y confunde que no puede con su alma físicamente con una sobrecarga emocional de su espíritu y le hace ilusión, bendita sea su inocencia si con ello es feliz. Es posible que existan otros síndromes literarios. Sin ir más lejos, Freud nos propone el complejo de Edipo y detrás de ése, tantos otros. Pero el síndrome de Stendhal es el más apasionado, inofensivo y bello de todos, al menos en su forma más leve, y procura divertimento y solaz a tantos turistas agotados por su peregrinación de monumento en monumento. La ocurrencia de la doctora Margherini merece un aplauso.
Ajeno a la fortuna que tendría su descripción de la emoción y el agotamiento que sintió después de visitar la Santa Croce, Stendhal siguió viajando y escribiendo. Regresó a Italia tiempo después, y viajo por la península varias veces antes de morir, finalmente, mientras aseguraba que él era más italiano que francés, algo que los franceses atribuyeron a su excentricidad, al puro capricho de un tipo voluble y singular.
El epitafio de su tumba está escrito en italiano. Dice:
«Arrigo Beyle, milanese. Scrisse, amò, visse Ann. LIX M. II. Morì il XXIII marzo MDCCCXLII»
El amigo Beyle, milanés. Escribió, amó, vivió.
Pero tengo que añadir que ya llevaba varios días en la ciudad y pocas veces había caminado tanto en mi vida. Aunque fue un momento emocionante ¡y vaya si lo fue!, tengo que señalar que la mayor parte de las veces se confunde el síndrome de Stendhal con puro agotamiento, insolación o deshidratación, y siento restarle emoción al cuento. Aunque la emoción la pone cada uno a lo que siente, por qué no. Si bien es cierto que casos clínicos de tan particular ansiedad se dan pocas veces al año en Florencia, se dan, y si un turista como un servidor de ustedes se emociona y confunde que no puede con su alma físicamente con una sobrecarga emocional de su espíritu y le hace ilusión, bendita sea su inocencia si con ello es feliz. Es posible que existan otros síndromes literarios. Sin ir más lejos, Freud nos propone el complejo de Edipo y detrás de ése, tantos otros. Pero el síndrome de Stendhal es el más apasionado, inofensivo y bello de todos, al menos en su forma más leve, y procura divertimento y solaz a tantos turistas agotados por su peregrinación de monumento en monumento. La ocurrencia de la doctora Margherini merece un aplauso.
Ajeno a la fortuna que tendría su descripción de la emoción y el agotamiento que sintió después de visitar la Santa Croce, Stendhal siguió viajando y escribiendo. Regresó a Italia tiempo después, y viajo por la península varias veces antes de morir, finalmente, mientras aseguraba que él era más italiano que francés, algo que los franceses atribuyeron a su excentricidad, al puro capricho de un tipo voluble y singular.
El epitafio de su tumba está escrito en italiano. Dice:
«Arrigo Beyle, milanese. Scrisse, amò, visse Ann. LIX M. II. Morì il XXIII marzo MDCCCXLII»
El amigo Beyle, milanés. Escribió, amó, vivió.

Texto: ©Luis Soravilla
CapGazette, junio 2015
CapGazette, junio 2015
Le barche. Le Drassanes e il Museu Marítim di Barcellona
On maggio 12, 2015 by Cap Gazette With 0 Comments
- Argumento - Argument - Argomento
Le Drassanes e il Museu Marítim di Barcellona
Dopo esser passate per il genovese e il veneziano, la ‘casa del mestiere' o la 'fabbrica’, custodite dalla parola araba Dār-ṣinā῾a, sono approdate nell'italiano sotto forma di 'darsena’ e 'arsenale’.
Nella città di Barcellona i più antichi arsenali marittimi, in catalano les drassanes, risalivano all’XI° secolo. Tuttavia, gli unici di cui oggi rimane testimonianza sono quelli che vennero costruiti ai piedi del Montjuïc a partire dalla seconda metà del XIII° secolo, sotto il regno di Pietro il Grande. Nel XIV° secolo, il re Pietro il Cerimonioso diede il via alla costruzione delle navate e l’arsenale assunse l’aspetto che tuttora conserva; si racconta che quell'ampliamento prese dimensioni tali che all'interno vi si potevano costruire contemporaneamente fino a 30 galere.
Nella città di Barcellona i più antichi arsenali marittimi, in catalano les drassanes, risalivano all’XI° secolo. Tuttavia, gli unici di cui oggi rimane testimonianza sono quelli che vennero costruiti ai piedi del Montjuïc a partire dalla seconda metà del XIII° secolo, sotto il regno di Pietro il Grande. Nel XIV° secolo, il re Pietro il Cerimonioso diede il via alla costruzione delle navate e l’arsenale assunse l’aspetto che tuttora conserva; si racconta che quell'ampliamento prese dimensioni tali che all'interno vi si potevano costruire contemporaneamente fino a 30 galere.

Quando nel 1369 si innalzò il terzo anello della cinta muraria cittadina, le darsene entrarono definitivamente a far parte del nucleo cittadino. Oggi sono la sede del Museu Marítim di Barcellona. Il centro propone un percorso tra le imbarcazioni che solcarono le acque catalane, mediterranee e oceaniche nel corso dei secoli, facendo rivivere al visitatore sia la storia medievale della potenza marittima catalano-aragonese, che quella delle navi moderne impiegate nella rotta d’oltreoceano. Tra barche da pesca di distinti tipi, navi da guerra e immagini di transatlantici il pezzo forte è senza dubbio la riproduzione de “La Capitana”, la Galera Reale di Giovanni d’Austria che venne costruita qui nel 1568 e che nel 1571 portò i cristiani a vincere i turchi nella battaglia di Lepanto; è lunga 59 metri ed è decorata con preziosi motivi barocchi dai colori rosso ed oro.

Non poteva mancare una riproduzione dell’'Ictineo', il primo sottomarino della storia che proprio nelle acque del porto di Barcellona si immerse nella seconda metà dell’Ottocento. Ci incuriosisce inoltre l'esposizione dei mascarons (mascheroni o polene), quelle figure in legno di uomini e animali selvaggi o mistici che venivano installate sulla prua per allontanare le forze occulte del mare. Qui la Blanca Aurora, il Negre de la Riba, il Ninot non sono altro che versioni ottocentesche dell'occhio protettore di Egizi e Fenici e delle sculture delle navi vichinghe. La scultura del Ninot, che è un ragazzino che porta in una mano un diploma di nautica e nell’altra un berretto da marinaio, è probabilmente la più nota in città grazie al fatto che sulla facciata di uno dei mercati primo novecenteschi più frequentati, chiamato appunto il ‘Mercat del Ninot’, è in bella mostra una sua riproduzione in bronzo.
Secondo la leggenda si tratterebbe di un mascaró appartenuto ad una nave di trasporto di schiavi naufragata nella costa barcellonese; si racconta che il capitano si salvò dal naufragio aggrappandosi al Ninot per raggiungere la città.
Appena messosi in salvo, il capitano festeggiò così di gusto e di bevute che quella notte dimenticò il mascherone in una taverna che si trovava di fianco ad un mercato, ancora senza nome...
Stando invece a un'altra versione, il Ninot sarebbe appartenuto ad una nave di bandiera italiana che in una notte di tempesta approdò nel quartiere della Barceloneta; una ragazza che passeggiava in riva al mare col fidanzato e i suoceri, vedendo arrivare la nave, mise alla prova il promesso sposo, chiedendogli di recuperare la polena della nave.
E l’innamorato così fece, la ragazza se ne tornò a casa col suo Ninot e il giorno dopo il padre, pure lui fiero della prodezza del genero, lo appese nella taverna che gestiva vicino ad un mercato.

L’edificio delle drassanes di Barcellona è uno splendido esempio di gotico civile catalano con una parte centrale formata da otto navi parallele ad archi semicircolari sostenuti da pilastri di sei metri. Anche se pare che dell’originario edificio rimanga solo la facciata marittima risalente al XIV° secolo, nel corso delle modifiche apportate successivamente si adottò la stessa tipologia costruttiva della struttura originaria; continuano dunque a risaltare alcuni elementi gotici tipicamente catalani e assenti nell'architettura dello stesso stile diffusasi nel resto d’Europa: gli archi semicircolari non delimitano un lungo corridoio slanciato verso il cielo, bensì grandi sale quadrangolari, che danno la sensazione di un unico ed ampio spazio e oltre alla pietra, materiale più rappresentativo del gotico europeo, si è fatto uso anche del legno.

Gli arsenali passarono sotto il controllo della corona di Castiglia a metà del XVII° sec., dopo la guerra dei Segadors (1640-1659) e con Filippo Vº furono destinati ad arsenale militare; solo nel 1935 l’esercito li cedette alla città di Barcellona.
Tra la prima metà del XIII° sec. e il XV°, in epoca d’espansione della marina catalano-aragonese, negli arsenali di Barcellona si costruirono imbarcazioni di tutti i tipi, dalle barche più piccole fino alle grandi navi commerciali che percorrevano le rotte verso il Levante e verso i paesi del Nord Europa. Il legno utilizzato proveniva prevalentemente dai boschi dei Pirenei, ma anche da quelli della Croazia e delle Fiandre. Al suo interno lavoravano i costruttori di corde (corders) e di remi (remolers) , i tessitori di vele (velers), i fabbri (ferrers) e i maestri d'ascia ovvero i falegnami marittimi (mestres d’aixa). Terminata e preparata la nave, i proprietari la affidavano al capitano (patrò). Con lui avrebbero viaggiato due scrivani-contabili, uno con il compito di controllare e segnare su un registro tutte le spese e le entrate del viaggio e l’altro responsabile della mercanzia lasciata a bordo al momento della partenza. Oltre a mozzi e marinai, non sarebbe mancato un barbiere, che all'occorrenza sarebbe diventato chirurgo, i trombettieri per gli ordini da trasmettere all’equipaggio, il maestro d'ascia e una persona che si sarebbe occupata dei salari.
Text: Nicoletta De Boni © CapGazette
Foto: © Renata Scanu
Maggio 2105
Da una nave russa a unaphotoalgiorno. Chiacchierata sulla fotografia con Graziano Paiella
Chiacchierata sulla fotografia con Graziano Paiella
Martedì 8 febbraio 2011 tira poco vento a Roma, il clima è mite e un anticiclone proveniente dalle Isole Azzorre rende la giornata umida e soleggiata. Mentre le temperature ondeggiano tra un minimo di 4 e un massimo di 16 gradi e qualche nuvola bassa si muove a traffico moderato sopra il Mar Mediterraneo e il Tirreno, Graziano Paiella prende di spalle Castel Sant’Angelo, ritraendolo oltre una finestra sporca. Gli aloni del vetro diventano sbavature dei raggi del sole e si confondono con la chioma cascante di un albero.
È in quel momento che egli decide che ogni giorno avrà la sua foto.
È in quel momento che egli decide che ogni giorno avrà la sua foto.
Siamo nella primavera del 2015 e la storia di unaphotoalgiorno è oramai una lunga storia, che continua. Quattro anni di fotografie scattate quotidianamente in Italia, ma qualche volta anche oltre confine, quotidianamente condivise nel suo profilo facebook e custodite nel sito www.grazianopaiella.com.
Di questa storia e d'altro abbiamo parlato con Graziano Paiella.
Di questa storia e d'altro abbiamo parlato con Graziano Paiella.
Mi incuriosisce innanzitutto sapere cosa ci fosse prima della sfida di quel martedì e quali foto prima di quella che ha dato il via a unaphotoalgiorno
Direi che la mia passione per la fotografia nasce con il regalo della mia prima macchinetta fotografica, una MINICOMET Bencini, un piccolo apparecchio anni '60. Con quello, a circa 7 anni, ho scattato le mie prime foto. Mi ricordo ancora quando i miei genitori ritirarono le stampe e mi dissero che alcune erano venute male, con strane inquadrature, io però le avevo scattate così apposta...
Poi un viaggio a Venezia, all’età di 17 anni, contribuì in modo determinante a consolidare questo amore. Ricordo una foto in particolare: era il 1977, una nave russa entrava nel canale con la sua falce e martello sulla ciminiera, io mi affrettai a scattare e solo dopo, con la stampa, mi accorsi che era entrato nell’inquadratura un gabbiano in volo, leggermente mosso. Mi conquistò. Credo che nella fotografia, come in tutte le arti, per un buon risultato debbano fondersi una serie di elementi, dalla tecnica, alla luce, al soggetto e qualche volta interviene il caso che rende il tutto più interessante. Non che nei miei lavori l'elemento casuale sia indispensabile, ma a volte può diventare un valore aggiunto, imprevedibile, e in quella foto di Venezia fu determinante. La scattai con un vecchio apparecchio a soffietto, una Kodak Retinette. Era di mio padre.
Tutte le immagini di unaphotoalgiorno, sono davvero tante, sono scattate con uno smartphone?
Sì, le immagini ad oggi sono circa 1500, è un po’ una follia, ma l’impegno quotidiano mi diverte e mi tiene allenato l'occhio. Da circa 5 anni le mie foto sono scattate quasi esclusivamente con lo smartphone. È un oggetto versatile, ma soprattutto è sempre con me.
La qualità non è alta, ma la velocità e l’immediatezza possono essere a volte molto utili. Mi basta vedere un luogo, un taglio di luce o qualcos’altro che attira il mio sguardo e sono pronto a fissarlo in un file. Tutto all’istante e un attimo dopo, posso condividere lo scatto con centinaia di persone.
Tutto ciò è affascinante per uno come me che viene dalla fotografia analogica, fatta di tempi lunghi ed attese per lo sviluppo e per la stampa. Senza nulla togliere a quel meraviglioso mondo della fotografia su pellicola, alla quale io sono molto affezionato.
Da quel che dici, capisco dunque che l'immediatezza con cui si può fruire delle immagini non ti sembra un limite, anzi, tutt'altro. Forse il fatto che si tratti di una foto al giorno, quindi di una storia che sappiamo che avrà un seguito, ci aiuta a non logorarle? È la costanza del tuo discorso fotografico a frenare un po' la velocità della fruizione?
Il ritmo incessante dello scorrere delle immagini al quale oggi siamo sottoposti è impressionante, ne siamo bombardati costantemente. Da quando ero bambino, dagli anni 70 ad oggi c’è stata un’immensa accelerazione del nostro rapporto con le immagini, sia con quelle in movimento, di cinema e televisione, che con quelle fisse. Questa sovraesposizione ha spinto inevitabilmente il video e la fotografia a progredire nel loro linguaggio e a sviluppare nuovi modi di vedere. Oggi, con la diffusione degli smartphone, siamo tutti fotografi o videomakers, tutti siamo in grado di leggere una buona fotografia. Facebook è un canale nel quale scorrono quotidianamente un illimitato flusso di parole ed immagini, sia video che fotografiche, e sono proprio queste ultime che moltiplicandosi in maniera esponenziale con la condivisione, lo rendono il social network più attraente. Ecco, a me piace immergere le mie foto in questo fiume, e quando il mio scatto condiviso blocca lo sguardo di qualcuno che clicca poi sul like, credo di essere riuscito a trasmettere qualcosa. Per me Facebook è una bacheca sulla quale posso fissare le mie fotografie, i momenti che vedo, come fossero post it con i miei appunti attaccati a una parete.
Il ritmo incessante dello scorrere delle immagini al quale oggi siamo sottoposti è impressionante, ne siamo bombardati costantemente. Da quando ero bambino, dagli anni 70 ad oggi c’è stata un’immensa accelerazione del nostro rapporto con le immagini, sia con quelle in movimento, di cinema e televisione, che con quelle fisse. Questa sovraesposizione ha spinto inevitabilmente il video e la fotografia a progredire nel loro linguaggio e a sviluppare nuovi modi di vedere. Oggi, con la diffusione degli smartphone, siamo tutti fotografi o videomakers, tutti siamo in grado di leggere una buona fotografia. Facebook è un canale nel quale scorrono quotidianamente un illimitato flusso di parole ed immagini, sia video che fotografiche, e sono proprio queste ultime che moltiplicandosi in maniera esponenziale con la condivisione, lo rendono il social network più attraente. Ecco, a me piace immergere le mie foto in questo fiume, e quando il mio scatto condiviso blocca lo sguardo di qualcuno che clicca poi sul like, credo di essere riuscito a trasmettere qualcosa. Per me Facebook è una bacheca sulla quale posso fissare le mie fotografie, i momenti che vedo, come fossero post it con i miei appunti attaccati a una parete.
Di questo tuo lungo reportage fotografico, oltre alla quotidianità, vorresti evidenziare altre costanti?
Altra costante è la parola ricerca, la ricerca nel quotidiano di immagini che riassumano un emozione o per isolare delle immagini dal fluire troppo veloce del nostro vedere, una ricerca per soffermarsi a guardare. Mi capita spesso di ricevere apprezzamenti per unaphotoalgiorno, anche da persone che non incontro abitualmente ma fruitori di Fb.
Altra costante è la parola ricerca, la ricerca nel quotidiano di immagini che riassumano un emozione o per isolare delle immagini dal fluire troppo veloce del nostro vedere, una ricerca per soffermarsi a guardare. Mi capita spesso di ricevere apprezzamenti per unaphotoalgiorno, anche da persone che non incontro abitualmente ma fruitori di Fb.
Alcune di loro mi raccontano che, seguendo il filo del mio discorso, sono state attratte e condizionate dal mio punto di vista ed hanno cambiato modo di fotografare. Ciò mi colpisce e, devo ammettere, mi gratifica molto.
Suggerire uno sguardo attraverso un’immagine credo sia una delle cose più affascinanti e anche più difficili per un fotografo. Vuol dire che l’immagine è stata recepita e si è fissata nella memoria e può aiutare nel tempo a vedere e guardare in modo diverso. Un po’ come il ritornello di una canzone che ci si ritrova a fischiettare inconsapevolmente. Per me la fotografia è una musica per gli occhi.
Le persone sono spesso assenti nelle tue foto, eppure quando io le guardo mi capita spesso di aspettare che qualcuno ritorni; voglio dire che gli spazi che ritrai mi sembrano luoghi momentaneamente, solo momentaneamente, abbandonati. Come se ci fosse sempre una voce in lontananza, che fa compagnia.
È bello quello che dici, grazie, rimanda ad un mio modo di essere. È vero, le persone spesso sono assenti, ma a volte entrano da sole in certe immagini, come il gabbiano. Arrivano improvvisamente e io le lascio lì! Sono volute entrare e io le lascio dentro! Le chiamo comparse.
Le persone sono spesso assenti nelle tue foto, eppure quando io le guardo mi capita spesso di aspettare che qualcuno ritorni; voglio dire che gli spazi che ritrai mi sembrano luoghi momentaneamente, solo momentaneamente, abbandonati. Come se ci fosse sempre una voce in lontananza, che fa compagnia.
È bello quello che dici, grazie, rimanda ad un mio modo di essere. È vero, le persone spesso sono assenti, ma a volte entrano da sole in certe immagini, come il gabbiano. Arrivano improvvisamente e io le lascio lì! Sono volute entrare e io le lascio dentro! Le chiamo comparse.
Tornando al tema del guardare, hai già parlato di "soglie" in occasione di una tua mostra a San Francisco.
La mostra del 2014 a San Francisco è stata una grande conferma dopo tanti anni di fotografie, finalmente la mia prima vera mostra fotografica. Titolo “Soglia”, “Treshold”. Il tema mi è stato suggerito dalla lettura di Lezioni di fotografia, bellissimo libro del maestro Luigi Ghirri. Per lui: «Fotografare vuol dire escludere, e questo si fa con l’inquadratura che è, appunto una soglia.
La mostra del 2014 a San Francisco è stata una grande conferma dopo tanti anni di fotografie, finalmente la mia prima vera mostra fotografica. Titolo “Soglia”, “Treshold”. Il tema mi è stato suggerito dalla lettura di Lezioni di fotografia, bellissimo libro del maestro Luigi Ghirri. Per lui: «Fotografare vuol dire escludere, e questo si fa con l’inquadratura che è, appunto una soglia.
[…] L’inquadratura non è solo bordo, ma una 'soglia': un punto nello spazio in cui si fronteggiano il mondo interiore del fotografo, io-pelle con occhio abnorme, e l’ammasso inerte e silente che sta fuori». Da queste parole ho tratto spunto per la mia mostra . La mia ricerca fotografica sulla soglia è stata una sfida nel trovare ulteriori soglie da inserire nell’inquadratura del paesaggio marino, con l’intento di portare lo sguardo dell’osservatore su un solo punto: l’orizzonte del mare. E allora nelle mie immagini appaiono elementi casuali atti a concentrare l’attenzione sulla linea di confine tra cielo e mare, elementi trovati sulle spiagge o sulle strade lungomare del Tirreno, Adriatico e Jonio. Vedere queste fotografie del paesaggio italiano nel contesto di una città come San Francisco è stato per me motivo di grande soddisfazione.
Oltre al tuo lavoro di regista e a Luigi Ghirri, chi o che cos'altro ritieni che ti abbia insegnato uno sguardo?
Ogni fotografo ci insegna a guardare le cose in modo nuovo, ma Luigi Ghirri per me è stato colui che ha condizionato ed emozionato con più forza le origini della mia fotografia. Poi ho scoperto Gabriele Basilico che ha influenzato il mio modo di vedere la città. Infine Hiroshi Sugimoto che ha sintetizzato il linguaggio fotografico con le sue foto dedicate al mare, cancellando il superfluo e riducendo la fotografia a una linea: l'orizzonte, il cielo sopra e sotto il mare, fotografato in diversi luoghi ed in diverse ore sulla terra.
CapGazette ringrazia Graziano Paiella e le sue fotografie
Oltre al tuo lavoro di regista e a Luigi Ghirri, chi o che cos'altro ritieni che ti abbia insegnato uno sguardo?
Ogni fotografo ci insegna a guardare le cose in modo nuovo, ma Luigi Ghirri per me è stato colui che ha condizionato ed emozionato con più forza le origini della mia fotografia. Poi ho scoperto Gabriele Basilico che ha influenzato il mio modo di vedere la città. Infine Hiroshi Sugimoto che ha sintetizzato il linguaggio fotografico con le sue foto dedicate al mare, cancellando il superfluo e riducendo la fotografia a una linea: l'orizzonte, il cielo sopra e sotto il mare, fotografato in diversi luoghi ed in diverse ore sulla terra.
CapGazette ringrazia Graziano Paiella e le sue fotografie
Clicca sulle immagini per entrare nel sito fotografico www.grazianopaiella.com
Chiacchiere: Graziano Paiella e Nicoletta De Boni © CapGazette
Foto: Immagini tratte dalla mostra 'Soglia' e 'Altare della patria', Roma 1967 © Graziano Paiella
Maggio 2015
Berlino-Barcellona, una conversazione con Lucia Chiarla
On marzo 15, 2015 by Cap Gazette With 0 Comments
- Diálogos - Dialoghi - Diàlegs
L’ultima volta che ho visto Lucia Chiarla c’era un incendio. Era la sera dell’11 aprile 1997 e a Torino bruciavano Palazzo Reale e la cupola del Guarini. Come molti altri curiosi, anche noi eravamo in Piazza Castello e osservavamo il fumo, le fiamme e il via vai dei pompieri. Correvano voci disparate su cause e danni del fuoco, lodi all’eroismo dei pompieri che, si diceva, venivano fin da Alessandria e Milano.
Da allora non ho più visto Lucia, ma un giorno, circa dieci anni fa, ero a radio Contrabanda di Barcellona per il programma in italiano Zibaldone quando Roberto Fenocchio, che dirigeva la trasmissione, ha dato notizia dell’uscita del film 'Bye Bye Berlusconi' di Lucia Chiarla e ...
- Chi? - Ho domandato.
- Lucia Chiarla e ….
- Lucia? La conosco!
Adesso che abbiamo un’età in cui si tirano alcune somme e si cerca di far quadrare comunque conti un po’ bislacchi*, ho lungamente conversato con Lucia via mail tra Berlino, Barcellona, Genova e Torino. Ecco il risultato di più di tre mesi di domande, risposte, considerazioni strappate alla foga della routine.
*[Bislacco, dice il vocabolario Treccani, viene forse dal veneto bislaco, soprannome che si dava ai Veneti del Friuli e agli Slavi dell’Istria, dallo sloveno bezjak «sciocco»].

Una definizione di Lucia Chiarla di teatro.
Il teatro è un gioco. Un gioco serio. L’obiettivo è dirsi la verità. Non ci sono vincitori e vinti. Solo buon teatro o cattivo teatro. Qualunque storia può raccontare una verità, se l’attore regala qualcosa di personale, e se il pubblico esce di casa per mettersi alla ricerca di sé, o degli altri. Lo spirito di ricerca è fondamentale. Gli attori possono essere aperti e generosi, ma se il pubblico non si è seduto con l’intento di ascoltare, allora non c’è dialogo. Un buon pubblico è importante quanto dei buoni attori.
Il teatro è azione e reazione. Non accontentarsi, né di sé né degli altri, non nascondersi dietro a estetismi o narcisismi mette lo scambio tra persone che indagano la vita al centro del teatro. Diciamo che è un gioco che non vuole ridursi a un passatempo. Quando si esce da teatro ci si potrebbe chiedere: ho trovato una chiave che non avevo? Ho capito qualcuno che non avevo mai capito, ho provato qualcosa che avevo paura di provare? E un attore che entra in scena si dovrebbe chiedere: dove sono io in questa storia? Sono disposto a spogliarmi per regalare qualcosa a chi mi ascolta?
Non so se questa è una definizione di Teatro, ma è il teatro che mi piace.
Come è nato in te l’amore per il teatro? Da piccola, da adolescente? Cosa ti ha portato al teatro?
Ho scoperto il teatro per solitudine. Da adolescente, credendomi diversa dagli altri e circondata da amici che si sentivano diversi dagli altri, oscillavo tra sentimenti di inadeguatezza e desiderio di esprimere la mia unicità. Dovevo innanzitutto capire in cosa consistesse la mia unicità!, e questa ricerca mi ha aperto le porte dell’ ”io”. L’ansia di trovarmi non si placava facilmente e per lo più restava insoddisfatta o si traduceva in amori infelici, desiderio di giustizia per tutti, rabbia verso ogni cosa mostrasse un equilibrio. Questi pensieri diventavano insopportabili la domenica pomeriggio e a quindici anni, per salvarmi dalla noia di quei lunghi pomeriggi inconsistenti a camminare avanti e indietro sul lungomare, ho cominciato ad andare a teatro, con le mie sorelle. In sala le luci si spegnevano lentamente e io scoprivo così, seduta tra donne imbellettate e profumate, la magia del teatro. I soli nemici di quei momenti erano i colpi di tosse di signore distratte che sfasciando caramelle mi riportavano alla realtà (fortunatamente non c’erano ancora i telefonini!). Quell’anno ho cominciato a frequentare un corso di teatro. Ero l’unica tra i miei amici ad avere un simile passatempo e questo mi rendeva poco cool, ma finalmente molto unica!, e per andarci dovevo prendere il treno che dalla provincia del ponente di Genova mi portava in centro città, passare tra i carruggi, percorrere salite sconosciute e parlare con persone stravaganti, che parlavano solo di teatro. Questo era solo l’inizio di un’avventura che si concludeva ogni volta nella lettura di poche battute. La ripetizione all’infinito di una frase e l’emozione che portava con sé calmava, anche se solo per pochi istanti, l’ansia di trovare delle risposte ai tanti "perché". Qualche anno dopo ho preso un treno che mi ha portata a Milano e lí sono rimasta per studiare teatro alla scuola d’arte drammatica fondata da Paolo Grassi. Poi ho continuato a cercare la stessa magia in altri teatri, in altri luoghi, salendo su altri treni.
Vent’anni dopo, ovvero oggi.

Oggi, vent’anni dopo, mi definisco un’attrice strana. Anzi, mi definisco un’osservatrice. Vivo a Berlino, dove si parla un’altra lingua, dove per il pubblico sono innanzitutto straniera. Questa condizione “strana” di “straniera” mi ha portato a ricercare da capo il senso della mia professione. Come se fossi rinata, o mi fosse data una nuova occasione per uscire dall’automatismo e riflettere. Nella ricerca mi sono accorta che la mia necessità è parlare di temi su cui ho urgenza di indagare, partendo dalla pura osservazione. E il mio modo immediato per elaborare questi temi è raccontando delle storie. A Berlino mi sono ritrovata a confrontarmi spesso con il tema del “vivere altrove” che è diventato anche titolo di uno spettacolo teatrale realizzato con il Teatro Instabile Berlino, con cui collaboro dal 2007. Poi ho sperimentato il racconto attraverso la canzone, insieme all'istituto di cultura italiano di Berlino, in uno spettacolo pensato per raccontare la cultura italiana attraverso la musica. Il titolo “d’Amore e d’Anarchia” cita un film di Lina Wertmüller. L’elemento amoroso e quello anarchico diventavano nel mio lavoro il filo d’Arianna per condurre lo spettatore tedesco - per il breve tempo di un’ora e mezza - lontano dai cliché sulla cultura italiana. E poi c’è il cinema, altro strumento di racconto che amo. Il mio primo film, "Bye Bye Berlusconi", di cui sono sceneggiatrice e interprete, presentato al festival di Berlino nel 2006, era un film che in forma di satira politica affrontava una tematica vicina a “I giusti” di Camus, in cui i personaggi si interrogano sul senso dei loro atti di giustizia e di morte. Della mia seconda sceneggiatura, a cui lavoro da diversi anni, in lingua tedesca, e che rappresenta il progetto più importante, vorrei raccontare poco. Una sceneggiatura, fino a quando non diventa un film non esiste per il pubblico. E come diceva Calvino nel Barone Rampante: “Le imprese che si basano su di una tenacia interiore devono essere mute e oscure; per poco uno le dichiari o se ne glori, tutto appare fatuo, senza senso o addirittura meschino.”!

Berlin
Kreuzberg

Faccio tesoro della tua citazione di Calvino e non indago oltre sulle “imprese”, in attesa della loro realizzazione. Buon lavoro, dunque. Come ti scrivevo, conosco bene la sensazione di spaesamento, “stranezza”, dici tu, forse straniamento, della vita all’estero. L'argomento è spinoso e forse anche in questo sarebbe opportuno dare retta a Calvino per evitare di sembrare presuntuosi e/o toccare "suscettibilità nazionali" e altre piaghe sensibili degli uni e degli altri. Ogni mio tentativo di spiegarmi, a quelli di qui e a quelli di là, come italiano a Barcellona finisce quasi sempre in una battaglia don chisciottesca. Tuttavia, se vuoi, possiamo fare l'ennesimo tentativo di spiegare le ragioni e le situazioni dell'espatrio, gli aspetti ricorrenti e quelli individuali. O cercarne il lato comico.
D'altro canto mi piacerebbe che ci parlassi degli spettacoli di teatro a cui hai assistito come spettatrice e che più ti hanno cambiata.
Ho provato a legare le due domande, ovvero io come straniera e lo spettacolo che in questo mi ha lasciato un segno.
Del “vivere altrove” ci sarebbe troppo da dire, e credo di essere ancora nella fase in cui questo troppo mi confonde. Quindi diciamo che è ancora presto per parlarne. Ad essere stranieri ci si abitua, come a tutto del resto, e mi consola pensare che anche quando vivevo nella mia città non mi sentivo mai completamente appartenente. Inizio a chiedermi se non sia una condizione del mio essere che con grande talento sono riuscita a rendere reale col mio trasferimento da ricordarmene perennemente, anche andando a fare la spesa. A questo proposito c'è uno spettacolo che ho visto e che mi accompagna in questa nuova fase della vita. Uno dei primi spettacoli visto a Berlino, in lingua tedesca: “Murx den Europäer! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn ab!” di Christoph Marthaler. Uno spettacolo cult in Germania che ho avuto la fortuna di vedere nella sua ultima rappresentazione, il febbraio 2006. Mi ero trasferita nel 2005, quindi ancora capivo molto poco di tedesco e della cultura tedesca. Lo spettacolo raccontava lo stato d’animo della popolazione della DDR poco prima della caduta del muro. Le parole non erano poi così importanti per la comprensione dell’opera. Quello che passava la messa in scena era un perenne sentimento di non appartenenza. I protagonisti, vittime di burocrazia, attese e assurdità, conservavano però un’ironia che diventava un collante salvifico. Ad ogni quadro si alzavano e intonavano insieme una canzoncina, molto nota in Germania : “Danke, für diesen guten Morgen”. Ovvero: “grazie, per questa buona mattinata! grazie”. Riscritta su una canzone da chiesa, con un testo pungente. Anch'io oggi, quando passo delle giornate a muovermi tra carte e faccende quotidiane, immersa nell’anonimato del sistema, con il mio numero di identificazione sotto mano per ogni cosa, canticchio quel motivetto e penso che l’ironia è l’unica salvezza.


Conversazione: Lucia Chiarla, Paolo Gravela
Foto: Paolo Gravela, Lucia Chiarla.
CapGazette, Mar. 2015
All’Isola di San Lazzaro degli Armeni. Seconda parte
On marzo 1, 2015 by Cap Gazette With 0 Comments
- Spazi - Espais - Espacios

Seconda parte
Per entrare nella chiesa del monastero di San Lazzaro degli Armeni si attraversa un chiostro rinascimentale che fa da corona a un piccolo giardino. Tra le piante troviamo un'antica glicine, dei roseti, un'Araucaria araucan, detta anche Pino del Paranà, e naturalmente l'albero simbolo dell'Armenia: il melograno. Nella mitologia greca il melograno viene associato alla dea Afrodite, ai cristiani ricorda la perfezione divina, per gli ebrei simboleggia la terra promessa, mentre i musulmani lo evocano contro l'odio e l'invidia. Nella parte settentrionale dell'isola i filari di pini si alternano a quelli dei roseti; è qui che vengono coltivate le rose da cui i frati ricavano il vartanush, la famosa marmellata fatta con i petali raccolti all'alba o al calar del sole durante il mese di maggio.
Su una parete del chiostro si leggono alcuni versi che sono stati tradotti dalla scrittrice italo-armena Antonia Arlsan e che sono tratti dal Ritorno di Daniel Varujan, il poeta armeno morto nel genocidio del 1915:
Questa sera veniamo da voi, cantando un canto, / per il sentiero della luna, / o villaggi, villaggi; / nei vostri cortili / lasciate che ogni mastino si svegli, / e che le fonti di nuovo / nei secchi irrompano a ridere. / Per le vostre feste dai campi, vagliando / vi abbiamo portato con canti la rosa. / Questa sera veniamo da voi, cantando l’amore, / per il sentiero della montagna, / o capanne, capanne; / di fronte alle corna del bue / lasciate che infine si aprano le vostre porte, / che il forno fumi, che si incoronino / di un fumo azzurro i tetti. / Ecco a voi le spose con i nuovi germogli / hanno portato il latte con le brocche. / Questa sera veniamo da voi, cantando la speranza, / per il sentiero del campo, / o fienili, fienili; / tra le vostre buie pareti / lasciate che risplenda il nuovo sole, / sui tetti verdeggianti / lasciate che la luna setacci la farina. / Ecco vi abbiamo portato il fieno raccolto in covoni / la paglia con il dolce timo. / Questa sera veniamo da voi, cantando il pane, / per il sentiero dell’aia, / o granai, granai; / nell’oscurità del vostro seno immenso / lasciate che sorga il raggio della gioia; / la ragnatela sopra di voi / lasciate che sia come un velo d’argento; / poiché carri, file di carri vi hanno portato / il grano in mille sacchi.
La chiesa mantiene la struttura a tre navate dell'originaria e trecentesca chiesa benedettina, ma dopo il primo restauro effettuato nel Settecento da Mekhitar, padre del monastero e dell'ordine, ha continuato a subire modifiche fino al secolo scorso. Al suo interno, come in tutte le chiese armene e in ricordo di una visione della Madonna avuta dal fondatore, c'è un altare consacrato alla Vergine; sopra l’altare principale i ritratti delle vetrate colorate raffigurano San Lazzaro, patrono dell'isola, e San Mesrop.
Fu quest'ultimo che, per poter tradurre la Bibbia, creò nel 405 l’alfabeto armeno, composto allora da 36 diversi segni, 7 vocali e 29 consonanti; Mesrop scelse allora anche il tipo di scrittura, da sinistra a destra, come nel greco, e non al contrario, come invece succedeva nella scrittura assira. Davanti all'altare maggiore può scorrere una grande tenda rossa che viene chiusa durante la Quaresima per separare la divinità dall’uomo e riaperta nel giorno della resurrezione, quando l’umanità è stata salvata dal peccato originale.
Alltri due ritratti vanno considerati piuttosto importanti per la storia religiosa armena: uno è quello di San Antonio Abate, qui però col volto di Mekhitar; infatti al momento della fondazione dell'ordine ci si rifece proprio alle regole di quello benedettino: ora et labora. L'altro è il ritratto di San Gregorio l'Illuminatore, grazie al quale nell'antica Armenia il cristianesimo divenne religione di stato.
La biblioteca e il museo si trovano al piano superiore; c'è un telescopio del Seicento posto accanto alla porta d’ingresso, a voler ricordare l’importanza che l’ordine mekhitarista ha sempre conferito agli studi e alla ricerca, quali mezzi che avvicinano alla verità o la svelano. Fu proprio grazie a questo che Napoleone considerò San Lazzaro degli Armeni più come un centro di studi e di cultura, che non come centro religioso, risparmiandone così la chiusura.
Il museo raccoglie molti oggetti un tempo appartenuti ai commercianti armeni. Uno dei pezzi più importanti della raccolta è la palla di Canton, opera di un monaco buddista che da una zanna di elefante ha ricavato una sfera d'avorio composta a sua volta da altre quindici sfere indipendenti l'una dall'altra e impreziosite con incisioni di scene della vita di Budda.
Nella biblioteca si trovano da una parte i libri religiosi e dall’altra i libri scientifici; superati gli scaffali si entra in una stanza con una serie di vetrinette che custodiscono oggetti di culto di vario tipo: una spada di Leone VI, ultimo re di Cilicia, ceramiche e monete, una maschera mortuaria del musicista armeno Komitas Vardapet, morto nel 1935 e artefice della raccolta delle più importanti musiche tradizionali armene. Nella successiva sala, detta di Byron e così chiamata perché il poeta inglese la usava come studio quando tra il 1815 e il 1817 soggiornò sull'isola, c’è un trono indiano del 1400 e la mummia egiziana del principe Nehmekhet, perfettamente conservata.
Fu quest'ultimo che, per poter tradurre la Bibbia, creò nel 405 l’alfabeto armeno, composto allora da 36 diversi segni, 7 vocali e 29 consonanti; Mesrop scelse allora anche il tipo di scrittura, da sinistra a destra, come nel greco, e non al contrario, come invece succedeva nella scrittura assira. Davanti all'altare maggiore può scorrere una grande tenda rossa che viene chiusa durante la Quaresima per separare la divinità dall’uomo e riaperta nel giorno della resurrezione, quando l’umanità è stata salvata dal peccato originale.
Alltri due ritratti vanno considerati piuttosto importanti per la storia religiosa armena: uno è quello di San Antonio Abate, qui però col volto di Mekhitar; infatti al momento della fondazione dell'ordine ci si rifece proprio alle regole di quello benedettino: ora et labora. L'altro è il ritratto di San Gregorio l'Illuminatore, grazie al quale nell'antica Armenia il cristianesimo divenne religione di stato.
La biblioteca e il museo si trovano al piano superiore; c'è un telescopio del Seicento posto accanto alla porta d’ingresso, a voler ricordare l’importanza che l’ordine mekhitarista ha sempre conferito agli studi e alla ricerca, quali mezzi che avvicinano alla verità o la svelano. Fu proprio grazie a questo che Napoleone considerò San Lazzaro degli Armeni più come un centro di studi e di cultura, che non come centro religioso, risparmiandone così la chiusura.
Il museo raccoglie molti oggetti un tempo appartenuti ai commercianti armeni. Uno dei pezzi più importanti della raccolta è la palla di Canton, opera di un monaco buddista che da una zanna di elefante ha ricavato una sfera d'avorio composta a sua volta da altre quindici sfere indipendenti l'una dall'altra e impreziosite con incisioni di scene della vita di Budda.
Nella biblioteca si trovano da una parte i libri religiosi e dall’altra i libri scientifici; superati gli scaffali si entra in una stanza con una serie di vetrinette che custodiscono oggetti di culto di vario tipo: una spada di Leone VI, ultimo re di Cilicia, ceramiche e monete, una maschera mortuaria del musicista armeno Komitas Vardapet, morto nel 1935 e artefice della raccolta delle più importanti musiche tradizionali armene. Nella successiva sala, detta di Byron e così chiamata perché il poeta inglese la usava come studio quando tra il 1815 e il 1817 soggiornò sull'isola, c’è un trono indiano del 1400 e la mummia egiziana del principe Nehmekhet, perfettamente conservata.


Al termine della visita risalpiamo in direzione della Riva degli Schiavoni e pare quasi di abbandonanare il leggendario paradiso terrestre delle antiche terre armene. Il buio è già sceso quando saliamo sul vaporetto; grazie a un miraggio, e a questa visita, l'imbarcazione si trasforma nell'Arca di Noè che, approdata nella notte dei tempi sull'Ararat, ora scende dal più alto monte d'Armenia e riprende il suo viaggio.
Text & Foto: Nicoletta De Boni © Cap Gazette
Marzo 2015
Copyright CAP gazette
GRAPHIC DESIGN By MINIUM DESIGN






